42..DICONO E HANNO DETTO DI..ROBERT PLANT E LED ZEPPELIN.."(interviste varie)
“È stato Plant a portare la bucolica campagna gallese nel processo creativo del gruppo. Letteralmente, Plant ha fornito le piante, le erbe e le radici, per gli incantesimi di Page.
Ha mancato di poco lo storico Sanremo del ’68 in cui si sono esibiti con Lucio Dalla e Bobby Solo, ma è colui che, quando il gruppo si è sciolto (cosa quasi nel DNA delle band di quel periodo) ha creato una band, denominata New Yardbirds, per soddisfare gli obblighi contrattuali di un tour in Scandinavia: «Ho sentito Robert Plant suonare nelle Midlands e l’ho invitato a casa mia per mostrargli cosa avevo in mente. Lui mi ha parlato di Bonham e quando siamo andati a sentirlo suonare ho sentito subito una grande affinità. Poi mi ha chiamato John Paul Jones chiedendomi se avessi per caso bisogno di un bassista, e il gruppo era fatto». Come Page, anche Jones viene da un periodo intenso e stressante di sessionman, al basso e tastiere: è la moglie che lo ha spinto a fare quella telefonata, ed è il collante delle straordinarie capacità soliste di chitarra e batteria. Affidata, questa, a John Bonham, le mani più pesanti del rock a venire, amico di scorribande fra balere e discoteche di Plant: «due grossi pesci rumorosi che nuotavano controcorrente, John con la sua incredibile tecnica ed esibizionismo, io col mio continuo, incessante ululato».
Sono i due meno esperti, e sul libro fotografico che ne celebra il 50enario, “Led Zeppelin by Led Zeppelin”, non ne fa mistero: «Che differenza avrebbe fatto una piccola sala prove a Chinatown? Quei due erano esotici, maturi, avevano stile e suonavano da sogno. Perché di questo si era trattato fino ad allora, di un sogno. Funzionavano a un altro livello, con una tale profondità e consapevolezza. Da un crescendo si passava al silenzio assoluto, e poi di nuovo gloriose esplosioni sonore». Dall’altro punto di vista, i due ’esperti’ li scrutano. Jones ricorda che «da bassista volevo vedere come se la cavava il batterista, se è mediocre non vale neanche la pena provarci. Mi sono reso conto subito che era un batterista straordinario e che c’era una grande sintonia». Aiuta il fatto che entrambi amino la black music di quegli anni, Motown e Stax e r’n’b: “ero un grande appassionato di jazz e r’n’b. Spesso la mia parte era complementare alla chitarra, e non c’è niente di meglio di un basso e una chitarra che suonano la stessa cosa”.
Insomma, è amore alla prima prova. Quel nome lì, però, suonava di vecchio. E allora, leggenda vuole, perché non usare quella battuta di Keith Moon, che doveva essere uno dei membri della super band abbozzata e mai quagliata, quella con Beck e Page alle chitarre? «It’ll go down like a lead balloon (affonderà come un pallone di piombo)», al che John Entwhistle (sempre Who, il quarto del supergruppo che non fu) aggiunse «like a lead zeppelin!». Leva una a dal lead, tieni il mitologico dirigibile Zeppelin, simbolo fallico di 200 metri se ce n’è uno, e il nome è cosa fatta. Niente scaramanzia. Tutto XXXL fin dall’inizio.
La descrizione di Plant dei pieni e dei vuoti sonori di quelle prime prove fotografa bene la dinamica che fin dall’inizio caratterizza gli Zeppelin. Loro e il gruppo che parallelamente ha messo in piedi Jeff Beck, con Rod Stewart alla voce, sono gli ultimi in scia di quell’amore per il blues elettrico afro-americano che non solo ha caratterizzato il secondo lustro degli anni 60 inglesi, ma ha letteralmente creato le basi del futuro rock (e derivati). Rispetto ai primi, però, gli Zep sono più focalizzati, hanno un repertorio e una capacità compositiva migliore, tecnica da vendere ma più al servizio del complesso. Non sono l’unione di tre solisti, come i Cream di Clapton, già sul punto del dissolversi, un po’ come l’era della psichedelìa con le sue jam senza fine. Sono davvero il modello della musica che verrà: stracarichi di riff – cioè l’essenza del r’n’r- ma anche in possesso di una vena melodica notevole, musica cazzuta ma senza (troppi, almeno all’inizio) deliri autoindulgenti che travieranno i loro emuli, capacità di improvvisazione, varietà di temi e di ispirazioni – non solo il blues di Chicago, ma anche il folk britannico.
“Led Zeppelin” è un debutto pazzesco sotto tutti i punti vista, uno quei dischi che cambiano il corso della storia: nel 1969, niente e nessuno ha il suono dei Led Zeppelin. Dopo, tutti cercheranno di avere il suono degli Zeppelin, ovviamente senza riuscirci. Perché la chimica fra i quattro – ognuno dei quali ricorda come molto speciale quella prima session di conoscenza reciproca, in cui hanno infilato i jack e acceso gli amplificatori e han cominciato a suonare ’Travelling Riverside Blues’ senza sapere cosa sarebbe venuto fuori – è di quelle che si crea una volta nella vita. Sono giovani e non si guardano indietro, sono istintivamente aperti a tutto quello che può succedere, flessibili e avventurosi. Sono magnificamente in connessione fra di loro: potenti ma precisi, al servizio di una costruzione d’insieme, ognuno non solo superbo tecnicamente – e cresceranno molto nel tempo- ma anche con una grande personalità musicale.
Il risultato è un blues progressivo, non più una copia ma un’evoluzione dell’originale a 12 battute, perfetto per i ragazzi degli anni 70, così diversi dai loro coetanei – o da loro stessi – solo pochi anni prima. Musica per teenagers headbangers con gli ormoni a palla ma anche per palati fini, perché la potenza è nulla senza controllo, e Page in controllo lo è pienamente.
«Jimmy Page, l’architetto sonico dei Led Zeppelin», ha scritto Mark Richardson su Pitchfork nella ennesima recensione postuma, «sentiva il blues in maniera diversa. In primo luogo come un suono, piuttosto che una forma o una tradizione o un prodotto delle personalità: forse è per questo che si sentiva così disinvolto quando ’prendeva in prestito’ dai dischi di blues senza riconoscere i crediti, perché non puoi fare il copyright di un suono. Sicuramente comprendeva l’elemento di induzione della trance attraverso la ripetizione del blues meglio di chiunque altro: blues come rituale di espansione della coscienza».
Gli epigoni avranno vita dura nel confronto, e la deriva verso l’heavy metal sarà inevitabile ma spesso solo per aspiranti, più che alla santità del rock, alla sordità col rock. Gli Zep non sono heavy metal: heavy sì, pesantissimi, ma Plant ha sempre detestato l’insinuazione. Guardando un giorno un poster dei Judas Priest ha detto «se sono responsabile di questo in una qualunque maniera, sono veramente imbarazzato». Per il suono e per il look.
La cosa veramente interessante, e anche un po’ più imbarazzante dei Judas Priest, è l’impatto di questo primo Lp su buona parte della comunità dei critici musicali di allora, Rolling Stone in particolare. La recensione d’epoca lo paragona molto sfavorevolmente (’tristemente reminescente’) a “Truth” del Jeff Beck Group che l’ha preceduto di poco, e aggiunge che Page, «pur competente chitarrista, è un produttore molto limitato e autore di canzoni deboli e senza immaginazione. Se vogliono riempire il vuoto lasciato dai Cream è meglio che si diano da fare e trovino materiale adeguato». In risposta, gli Zeppelin per tutta la carriera non concederanno mai un’intervista alla più importante rivista americana. Non ne avranno bisogno. Ma com’è possibile che abbiano cannato in questa maniera?
Piuttosto incredibile, anche se 50 anni dopo RS, approfittando di uno dei tanti repackaging che i dischi degli Zep hanno avuto negli ultimi 30 anni, ne pubblicherà una che sa di penitenza in piena regola. Difficile capire il perché di questo ostracismo, che durerà non pochi anni. Io il mio impatto da sedicenne con ’Dazed and Confused’ me lo ricordo come fosse ora: in salotto, ascoltando la radio, che certo non suonava come uno stereo, rimasi choccato, pensavo fossero atterrati i marziani e avessero cominciato a fare dischi. Non era il primo disco che ascoltavo, c’erano già stati gli Who e Jimi Hendrix, ma la sensazione era che nessuno avesse mai suonato una musica così potente, fisicamente trascendente, spaced out, apocalittica. Così rock, anche se il termine sarebbe stato certificato dopo l’avvento degli Zep.
Come l’iconica copertina, rielaborazione grafica di George Hardie del Luftschiff Zeppelin Hindenburg #129 che prende fuoco e fa una strage nel 1937 atterrando nel New Jersey dopo una transvolata oceanica, i Led Zeppelin promettono dall’inizio fuoco e fiamme, un’apocalisse bombastica. E lo fanno con la produzione di Page, che è tutt’altro che limitata: è essenziale, attenta a mettere a terra tutta la potenza della band che si riunisce in sala di registrazione nell’ottobre 1968, circa due mesi dopo il loro primo incontro e il tour svedese. Page ha già una bella esperienza in studio, è stato uno dei musicisti più richiesti come turnista di lusso negli anni precedenti, lo trovate (accreditato o meno) in centinaia di brani. È ricco, già a modo suo una star riconosciuta, ma vuole creare qualcosa di nuovo.
In un’intervista a Phil Alexander su Mojo, racconta la visione iniziale: «La mia collezione di dischi era veramente eclettica. Tutti avevano dischi di r’n’r, magari con i dischi blues del catalogo Chess. Ma io avevo musica da sitar, araba ed elettronica. Ero appassionato di musique concrete dove la musica viene tagliata, un equivalente musicale del lavoro di cut up di Burroughs. Mi piaceva anche la musica classica, tradizionale e moderna. Negli Yardbirds avevo cominciato a fare una musica che missasse musiche, tessiture e suoni diversi. Ho continuato in questa direzione coi Led Zeppelin. Cercavo di creare qualcosa che non si fosse mai sentito prima, o comunque non si fosse mai sentito come lo suonavamo noi. È quello che ho cercato di fare fin dai primi accordi di ’Good Times Bad Times’».
Quella doppia pennata di chitarra che arriva a sorpresa da subito e poi continua a ripetersi con la violenza di un martello, il charleston che come un metronomo tiene il tempo, il campanaccio che lo raddoppia e la rullata che introduce la voce di Plant sono l’inizio della leggenda, un riff r’n’b di Jones a tenere insieme le varie stanze della canzone. Nonostante la canzone potrebbe essere un pezzo pop anni 60, c’è una brutalità che non lascia nulla di inespresso. Quando a 1’30” parte un assolo di 20” di cattiveria inaudita si capisce che c’è poco da scherzare.
Qui si fa sul serio, e Page ha l’esperienza per sapere quanto sia importante catturare la energia cruda delle performance, sempre in presa diretta, con poche sovraincisioni. Negli Olympic Studios, ingegnere del suono quel Glyn Johns che lavora con Who e Stones, dispone i microfoni in vari punti della sala. È lo stesso effetto dei dischi di blues della Chess, allora ancora in mono, per avere un suono d’ambiente, in cui la pulizia non è in cima alla lista delle priorità, anche se ogni strumento è scolpito e potente di suo. La batteria di Bonham viene posta su una pedana per amplificarne la potenza, «catturare ogni frequenza proveniente dalla batteria era fondamentale per sentirla respirare mentre veniva suonata». Nel mix, il basso assurge a un volume e a un’importanza da colonna del tempio. Ogni singolo suono o strumento è definito, ognuno aggiunge la sua parte al suono d’insieme, più grande della somma delle sue parti, ed è questo il segreto del trionfo sonoro di “Led Zeppelin” e delle otto produzioni discografiche in studio – tutte firmate da Page – che seguiranno, dal ’79 al ’91.
Il secondo brano dichiara subito che non sarà tutto heavy, che c’è spazio per un lato acustico. ’Baby I’m Gonna Leave You’ è un brano anni 50 della folksinger americana Anne Bredon, ed è il primo brano che Page fa sentire a Plant, già tutte le parti di chitarra in testa, quando viene a trovarlo sulla sua nuova casa sul fiume a Pangbourne, fuori Londra. Lo sentono dall’album “In Concert” di Joan Baez, che riprendendola l’ha firmata ’traditional, arrangement Joan Baez’ senza citare l’autrice, e così anche Page se ne intesta l’arrangiamento. Non è l’unica dimenticanza riguardo ai crediti dell’album (dal ’91 dopo una causa sarà co-intestata), ma almeno l’arrangiamento qui c’è, perché quella che è una ballata a un certo punto si ferma e diventa heavy, una tempesta di basso e batteria, la voce di Plant alta e sofferta, poi ritorna acustica e poi ritorna dura e poi di nuovo acustica e poi di nuovo come un tuono, la battuta sul quarto quarto fenomenale, memorabile come quella di ’Gimme Some Lovin’. Sul finale, la chitarra filtrata attraverso un altoparlante Leslie cede di nuovo il passo alla melodia folk, un’alternanza che è la sintesi di due anime, una scelta di dinamica estrema che sarà sempre una delle matrici del gruppo (si pensi alla ’Stairway To Heaven’ che è ancora lontana).
Terzo brano, altra influenza in primo piano: ’You Shook Me’ è il migliore dei due brani presenti del principale autore blues degli anni 60 (oltrechè contrabbassista in house della Chess Records) Willie Dixon, scritto sette anni prima per Muddy Waters. È la radice primaria della musica degli Zeppelin, e se cercate un esempio di come i quattro hanno trasformato il blues afroamericano, questo è quello giusto. La chitarra di Page acida e durissima con una spruzzata di psichedelìa, la voce di Plant altissima, feroce, il basso e la batteria così heavy che ogni battuta sembra il passo di un gigante che fa tremare il suolo dove cammina: «Non è facile essere così funky con un brano lento, ma John c’è riuscito». Jeff Beck l’ha proposto per primo in “Truth”, accusando l’ex compagno di avergli rubato l’idea. Il confronto è utile per capire le differenze di approccio, quello degli Zeppelin oggettivamente più riuscito.
Attaccato, senza pause, arriva ’Dazed and Confused’, musica così solida e allo stesso tempo così liquida in certi passaggi, una sorta di jam improvvisata durante la quale – artificio già messo in pratica con gli Yardbirds- Jimmy Page imbraccia l’archetto del violino e suona la sua elettrica con effetto che di volta in volta è melodico, dronico, irreale, spaziale, marziano. La carica dei quattro dell’apocalisse poi parte di colpo e si fa orgia elettrica, un fiume in piena che trascina via tutto, tonalità sempre più alte, finchè le rullatone di Bonham riportano tutto alla base, per un attimo torna il blues primordiale in mezzo a un vortice di effetti, volume che si impenna e poi si placa. Sempre Page: «per certi versi, è disturbante da ascoltare. Ma era voluto. Non voleva essere educata. Voleva creare un disturbo nella tua mente». Anche ’Dazed and Confused’, firmata sul disco da Page, è in origine una folk song, questa di Jack Holmes, cantautore americano che ha suonato, guarda caso, come apertura in un concerto degli Yardbirds a New York. Rimarrà sempre uno dei brani centrali degli Zeppelin dal vivo, improvvisata e strecciata a volte fino alla mezz’ora.
Una intro classicheggiante all’organo da parte di Jones apre la seconda facciata, chitarra acustica e melodia, e alla fine delle strofe una sorta di gospel, minaccioso però: ’Your Time Is Gonna Come’, la ritmica che scandisce e la pedal steel guitar che innalza. Lo strumentale ’Black Mountain Side’, basato sull’arrangiamento del traditional ’Black Water Side’ di uno dei maestri del folk britannico Bert Jansh, doppia chitarra acustica sovraincisa e tabla di Viram Jasani, è un assaggio ulteriore di quel lato acustico, più celtico che country, che sarà sempre presente nei loro album, una vetrina per i virtuosismi di fingerpicking di Page.
’Communication Breakdown’ è il rock veloce dell’album, la voce di Plant che sale sopra la chitarra di Page già alta di suo: come nelle improvvisazioni vocali, come nei blues tirati per il collo e in ogni direzione, la voce di Plant è assolutamente fondamentale per il suono nell’insieme. «Uno strumento a sé stante», dice Page sempre su Mojo, «non volevamo un crooner che cantasse sopra quello che stavamo suonando. Volevamo qualcuno che suonasse totalmente disinibito. Primordiale! Era chiaro fosse un ginnasta vocale, e sapesse anche improvvisare. E anche questo era super importante per me. Volevo uno che improvvisasse e che si mangiasse le canzoni».
Il secondo blues di Dixon, ’I Can’t Quit You baby’ (l’originale nel repertorio del grande Otis Rush) porta all’ultimo brano dell’album, ’How Many More Times’, e sono 8’30” di tour de force da mozzare il fiato. Una chitarra wah wah filtrata apre, e poi arriva tutto il resto dell’artiglieria, il riff di base con un incedere da battaglia campale e i break di chitarra che arrivano fino in cielo mentre Bonham sotto rulla come non ci fosse un domani. Dentro c’è di tutto, dalle citazioni blues di ’How Many More Times’ di Howlin’ Wolf al Bolero di Ravel, finchè si scivola in un’improvvisazione quasi ambient, un drumming leggero che fa da appoggio per la parte solista di Plant. Canta, si lamenta, urla e strepita istrionicamente mentre il suono alle spalle cresce, cresce ancora e alla fine si trasforma in una sorta di heavy hip-hop antelitteram, un controtempo tostissimo che sfocia in ’The Hunter’ di Albert King (scritta da Booker T. & the MG’s, la stratosferica studio band della Stax). Poi riparte daccapo il riff iniziale, sempre più torrenziale, e si chiude nel delirio sonico con un ultimo sbreng!.
Se l’avete sentito a volume, diciamo, adeguato, il silenzio cala come un vuoto, le orecchie che risuonano e la sensazione di essere appena passati attraverso una tempesta. Tipo quando in autostrada incocci un diluvio che di colpo finisce e c’è il sole, e ti chiedi «whew, che è successo?».
Questo è l’effetto che più di 50 anni dopo ancora porta con sè il debutto degli Zeppelin. Immaginatevi allora, con l’effetto-prima-volta. Stordente, e così sarà il format per tutta la loro corsa. «Pensavo, prima ancora di avere il gruppo, che se un album fosse stato realizzato con abbastanza contrasto, con abbastanza drammaticità, quello che chiamiamo luce e ombra, e poi le parti vocali, e la chitarra suonata in modo superheavy, sarebbe stato incredibile. È ciò che abbiamo tentato di fare».
Vera mente di tutta l’operazione, Jimmy Page paga con i suoi soldi la produzione, duemila sterline per 30 ore di studio in nove giorni missaggio incluso, e con il gigantesco (e cattivissimo) manager Peter Grant contatta a New York la Atlantic di Ahmet Ertegun e Jerry Wexler: «Ci siamo presentati con il disco già finito, e quindi potevamo imporre le nostre condizioni. Era un affare da prendere così o lasciare. Hanno capito che era musica radicale, non avevano mai sentito nulla del genere».
Firmano subito, obiettivo il mercato degli album, nei patti anche nessun singolo (ma il patto verrà sospeso per ’Whole Lotta Love’), e pieno appoggio. Nessuna apparizione televisiva, centinaia di interviste solo alle radio FM underground americane: «a volte anche in un tenda nel mezzo del nulla, ma solo con gente che capiva e amava quello che facevamo». Lentamente, per passaparola ed entusiasmo crescente, gli Zeppelin passano dal Marquee a Londra ai due Fillmore, East and West a NYC e San Francisco, e presto arriveranno i tutti esauriti negli stadi.
In un solo anno, “Led Zeppelin II” uscirà sei mesi dopo, scrivono la loro storia di how the west was won.
------------------
56...♪♫LIVE E PERFOMANCE LED ZEPPELIN♪♫.
https://youtu.be/QUv9uYupofI Led Zeppelin - Live in Bradford, UK (Jan. 18th, 1973) Rock and Roll, Over the Hills and Far Away, Black Dog, ...
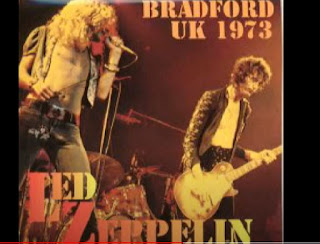
- https://concertionline.com/tag/robert-plant/ pistoia blues 2014 https://concertionline.com/.../robert-plant-live-at.../ http://tradelist...
- Chissà dove va tutto l'amore che abbiamo provato per coloro che non hanno saputo cosa farsene." io ho una risposta.. l'amor d...












Nessun commento:
Posta un commento